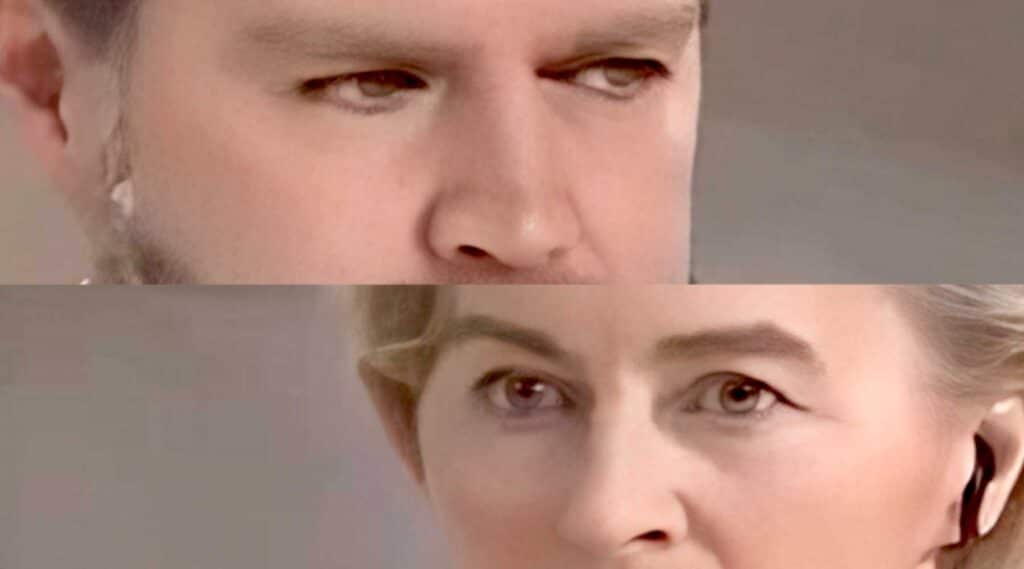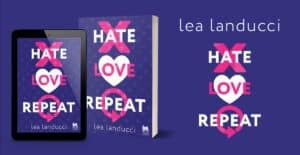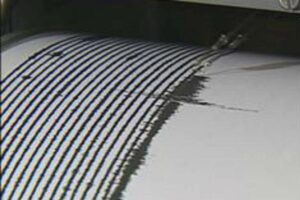L’immagine è chiara:
Ursula von der Leyen ascolta J.D. Vance con un’espressione tra l’incredulo e il contrariato. Il vicepresidente americano le sta spiegando, senza troppi giri di parole, che il modello europeo di regolamentazione dell’intelligenza artificiale è più un ostacolo che una tutela. Le sue parole sono dirette, il tono pragmatico. L’episodio, avvenuto durante il Summit di Parigi, non è un dettaglio da trascurare.
Sul palco si discuteva di IA, ma il vero tema era un altro: Stati Uniti ed Europa condividono ancora un orizzonte politico comune o stanno sviluppando strategie inconciliabili?
Vance ha chiarito la posizione americana: meno burocrazia, più spazio all’innovazione. Von der Leyen ha ribadito la necessità di un quadro normativo stringente, un principio che suona rassicurante in teoria, ma che rischia di rivelarsi una zavorra. Sullo sfondo, la Cina procede spedita, sviluppando modelli IA copiati e ridistribuiti come open-source, aggirando con disinvoltura regole e brevetti. Il problema, quindi, non è solo la regolamentazione dell’IA, ma il ruolo dell’Europa in un mondo che si muove con altre logiche.
Negli Stati Uniti il cambiamento politico ha preso una direzione netta: l’elezione di Trump ha ridefinito le alleanze internazionali e rimescolato le priorità strategiche. In Europa, invece, tutto procede con maggiore cautela e, in alcuni casi, con evidente indecisione.
Le forze politiche che fino a pochi anni fa venivano definite “destra radicale” stanno guadagnando spazio, ma il loro ingresso nelle istituzioni avviene in modo eterogeneo e spesso con un abbassamento del tono rispetto alla fase iniziale. Quella che era un’esplosione di retorica antisistema si sta trasformando in un esercizio di gestione del potere che, inevitabilmente, porta con sé compromessi e assestamenti.
Al di là della propaganda, molti di questi partiti si trovano oggi a dover tradurre la loro retorica in azione politica, con inevitabili attriti con la realtà delle istituzioni. Questo processo può essere visto come una maturazione politica, ma solleva interrogativi sulla capacità di mantenere coerenza con le promesse iniziali.
MEGA (Movement for a Europe of Great Ambitions) punta a unire le diverse anime del movimento conservatore, ma il successo dipenderà dalla capacità di costruire una visione comune. Se resta una coalizione definita più dall’opposizione ai modelli esistenti che da una strategia solida, difficilmente potrà evolvere. Al contrario, un adattamento privo di direzione rischierebbe di disperderne la spinta iniziale.
Se c’è un tratto distintivo della governance europea, è l’insistenza sulla regolamentazione preventiva. Non è una novità, né un principio sbagliato in sé. Il problema sorge quando più norme significano meno innovazione.
L’intelligenza artificiale è solo l’ultimo esempio. Il modello DeepSeek, sviluppato in Cina con il reverse engineering di ChatGPT e distribuito come open-source, dimostra quanto l’equilibrio tra protezione e sviluppo sia tutto fuorché risolto. L’Europa, bloccata in un limbo tra regolamentazione e prudenza, rischia di vedere le proprie preoccupazioni trasformarsi in opportunità per altri. Non si tratta solo di una questione tecnica: l’incapacità di definire una linea d’azione coerente rende l’UE un attore secondario nel panorama globale. E il paradosso è che proprio la rigidità normativa potrebbe finire per produrre effetti contrari alle sue intenzioni, con la tecnologia sviluppata altrove che trova comunque il modo di entrare nei mercati europei.
Negli Stati Uniti il dibattito politico è aspro ma definito. L’Europa, invece, sembra oscillare tra modelli inconciliabili. La volontà di mantenere una centralità nelle decisioni globali si scontra con la difficoltà di conciliare visioni diverse, sia a livello istituzionale che all’interno dello stesso fronte conservatore.
La questione non è se l’Europa debba seguire il modello americano, ma se sia ancora in grado di decidere autonomamente la propria traiettoria. I prossimi anni diranno se il continente riuscirà a costruire un’identità politica più incisiva o se continuerà a muoversi in una condizione di ambiguità che, nel lungo periodo, potrebbe rivelarsi insostenibile.
L’Europa è a un bivio. La regolamentazione dell’intelligenza artificiale è solo il sintomo di una sfida più ampia: rimanere un polo decisionale rilevante in un mondo che cambia rapidamente o restare intrappolata nella propria prudenza. Non si tratta di scegliere tra il modello americano o cinese. Si tratta di decidere se l’Europa avrà la forza di esprimerne uno proprio.