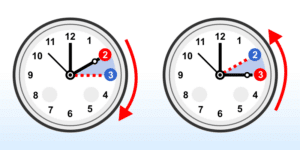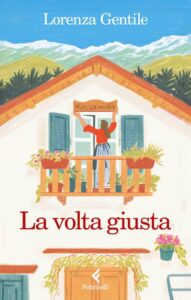Davvero la politica aveva programmato che il nostro tessuto produttivo avrebbe dovuto contrarsi? Un interrogativo che tocca le corde più intime del nostro vivere quotidiano, del nostro presente e del nostro futuro.
La domanda centrale del saggio dell’economista Antonino Galloni si inserisce in una riflessione più ampia sulla direzione che ha preso l’economia italiana negli ultimi decenni, mettendo in discussione le politiche che hanno portato alla contrazione del nostro apparato produttivo e alla privatizzazione delle nostre aziende strategiche.
Nel suo saggio, Galloni esamina e ripercorre i principali eventi storici e politici che hanno caratterizzato l’evoluzione economica dell’Italia a partire dagli anni ’80, focalizzandosi in particolare su un momento cruciale: l’ingresso del nostro Paese in una “Confederazione di Stati”, ovvero l’integrazione nell’Unione Europea e l’adozione di politiche neoliberiste, che, secondo l’autore, hanno avuto ripercussioni devastanti sul nostro tessuto produttivo.
La prima domanda che Galloni si pone riguarda la possibilità che la politica avesse pianificato una contrazione del nostro apparato produttivo. A partire dalla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, l’Italia è stata soggetta a una serie di riforme che, pur con l’intento di modernizzare l’economia, hanno avuto come conseguenza una riduzione della capacità produttiva nazionale. L’industria italiana, una volta fiore all’occhiello della nostra economia, ha visto progressivamente smantellare la sua struttura, non solo per motivi di mercato ma anche per decisioni politiche che hanno privilegiato la speculazione finanziaria rispetto all’innovazione tecnologica e all’espansione della produzione.
Un progetto politico o una casualità? Secondo Galloni, non è affatto casuale. La politica delle privatizzazioni, che ha caratterizzato gli anni ’90, ha visto lo smembramento delle grandi aziende pubbliche italiane, molte delle quali erano leader mondiali nei loro settori, in favore di interessi esteri e finanziari. La privatizzazione delle aziende strategiche, come l’Enel, Telecom Italia, e l’Alitalia, ha portato non solo alla perdita di autonomia economica, ma ha anche messo in discussione la possibilità di un vero sviluppo del Paese, consegnando di fatto il nostro futuro nelle mani di soggetti che non avevano alcun interesse a preservare l’indipendenza economica e la crescita sostenibile dell’Italia.
Il passo successivo in questa analisi riguarda l’ingresso dell’Italia nell’Unione Europea, e più precisamente nell’adozione dell’Euro. Galloni sostiene che le politiche imposte dall’Unione Europea, in particolare le politiche fiscali e monetarie, abbiano avuto un impatto diretto sull’industria italiana, riducendo la competitività delle nostre imprese. La rigidità del patto di stabilità e le politiche di austerità hanno imposto un quadro normativo che non ha favorito l’innovazione, ma anzi ha costretto le imprese italiane ad adeguarsi a parametri economici che non riflettevano le peculiarità della nostra economia.
Il tema della “Confederazione” diventa, per Galloni, simbolo di un processo che ha impoverito non solo il nostro apparato industriale ma anche la nostra sovranità economica. “Perché avremmo dovuto accettare di entrare in una Confederazione di Stati?”, chiede Galloni, suggerendo che l’integrazione nell’Unione Europea non è stata semplicemente una scelta geopolitica, ma una vera e propria imposizione economica che ha determinato una serie di scelte strategiche sbagliate, che hanno indebolito la capacità di autogoverno del nostro Paese.
Una delle accuse più gravi che Galloni muove riguarda la stagione delle privatizzazioni, che ha interessato decine di aziende pubbliche italiane. La logica delle privatizzazioni, secondo l’autore, ha avuto l’effetto di svendere il patrimonio strategico del Paese, creando un circolo vizioso di indebitamento e disgregazione industriale. Le privatizzazioni sono state presentate come una soluzione per modernizzare l’economia italiana, ma in realtà hanno comportato una concentrazione del potere economico nelle mani di pochi gruppi finanziari, anche stranieri, che hanno progressivamente ridotto la capacità produttiva del Paese.